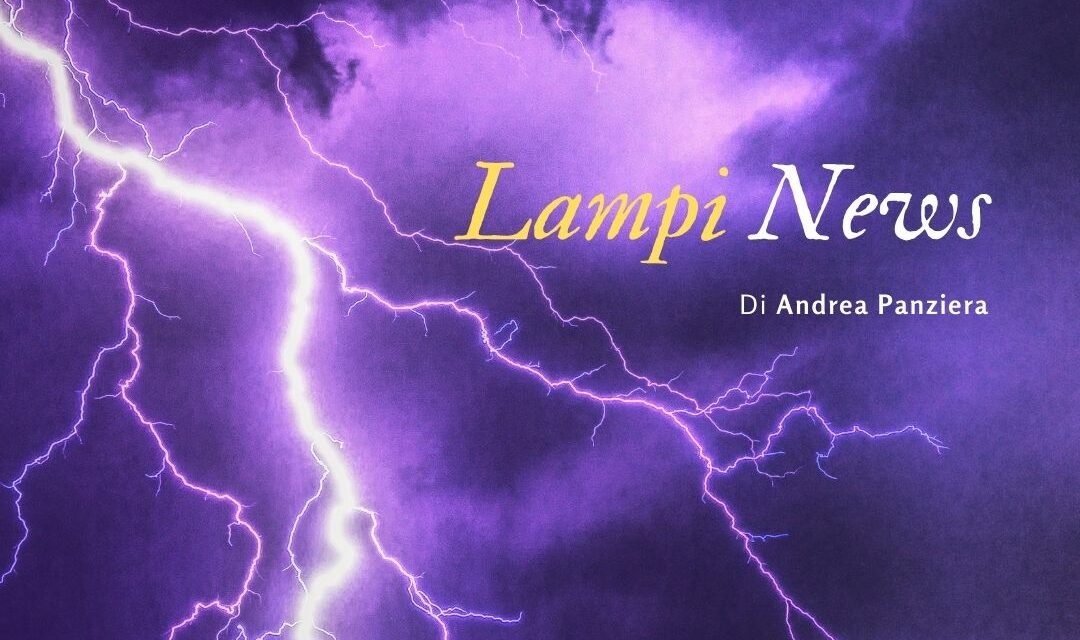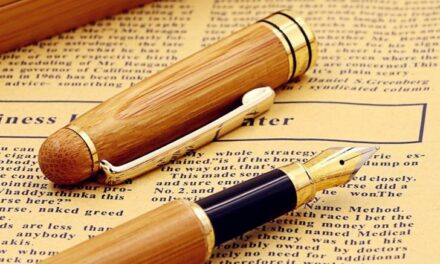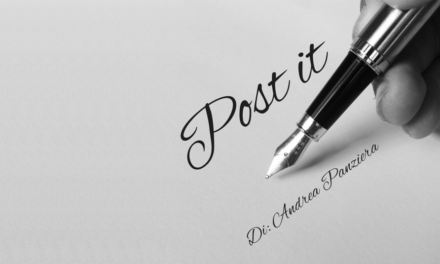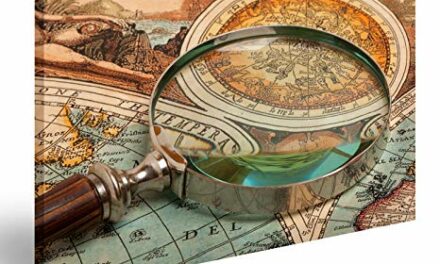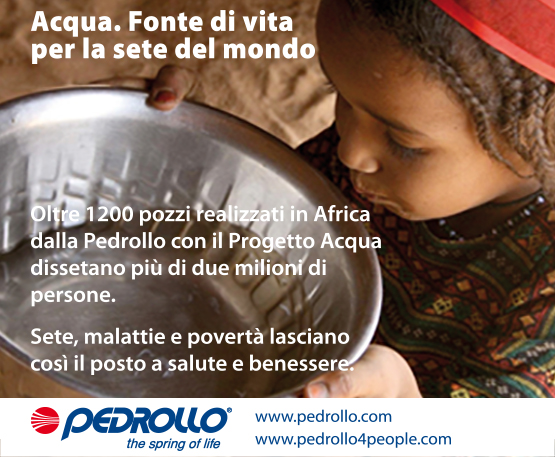Il bluff dei dazi e l’illusione del compromesso: così l’Europa finisce per applaudire una sconfitta mascherata da vittoria diplomatica
Di: Andrea Panziera
LEGGI ANCHE: Lampi News – La Strumpgata
È proprio vero, neanche i bulli sono più quelli di un tempo. Una volta brillavano per la loro spavalderia, la sfrontatezza, ma in fondo erano simpatici e la sfacciataggine esibita a più non posso almeno faceva sorridere, perché l’evidenza testimoniava la loro innocuità. Memorabile a tale proposito rimane il film pluripremiato di Joseph Mankiewicz, con Frank Sinatra, Jean Simmons e Marlon Brando, un cast da parterre de rois.
Qualcuno obietterà che finzione cinematografica e realtà spesso divergono per distanze abissali; vero, ma la prima non di rado rappresenta lo specchio non troppo infedele dei tempi che corrono e oggi una pellicola con quella trama, quella spensieratezza un po’ guascona, furbacchiona ma tutto sommato lieve ed inoffensiva, sarebbe del tutto improponibile.
Non tanto per il ruolo attribuito alle figure femminili, le quali ora come allora devono lottare con le unghie e con i denti per ottenere le posizioni di leadership che, per doti intellettive e capacità operative, di sicuro meriterebbero in misura molto maggiore di quella attuale.
Mi riferisco, per coloro i quali non l’avessero ancora compreso, al ruolo dei bulli, i cui epigoni popolano in grande quantità la scena socio-politica internazionale. Con una doverosa aggiunta: il sistema Italia, sotto questo punto di vista, non fa eccezione e rappresenta una ben fornita riserva faunistica della specie.
Sì, perché il bullo moderno, oltre alla tollerabile e congenita spavalderia, ha sviluppato altre doti meno encomiabili: l’arroganza, la prepotenza, il teppismo pubblico e istituzionale, degradando le alte funzioni ricoperte a meri contenziosi sull’uso senza freni della forza.
Ometto ogni commento sulla deriva del linguaggio, povero di contenuti, ma farcito di abiette provocazioni e gratuite scurrilità. In sintesi, la logica oggi imperante è “io ho ragione non perché posso provarlo con ragionamenti e dati oggettivi, ma semplicemente perché sono nella condizione di farti del male e quindi devi accettare i miei “desiderata” o, in caso contrario, accettarne tutte le inevitabili conseguenze”.
Conosco già le obiezioni: in fondo, la Storia ci ha tramandato secoli di narrazioni connotate da queste prassi e gli ultimi ’80 anni, pur con qualche momento di tensione, hanno rappresentato un periodo felice dopo una successione interminabile di conflitti. Il problema è che molti di noi si erano illusi; la culla dell’acquisita pacifica convivenza aveva ingenerato nelle menti la convinzione di una pressoché globalmente condivisa primazia del confronto come strumento per risolvere ogni qualsivoglia controversia.
I fatti e gli atti, più che le parole, sembrano dimostrare che quasi certamente siamo in presenza di un grave errore di valutazione collettivo. Tutto questo lungo preambolo non è solo propedeutico alla valutazione, che seguirà a breve, sulla vicenda “dazi”, ma ne rappresenta l’imprescindibile prologo.
Nei giorni scorsi, prima di scrivere questo pezzo, mi sono divertito a leggere i vari commenti pubblicati qui e là sulla portata e sulle possibili conseguenze dell’accordo. Ebbene, lo confesso, la mia sensazione, che si sta rafforzando ogni giorno che passa, è quella di un gioco delle parti con gli attori di fatto pienamente in commedia ed un finale ancora tutto da scrivere. Finora, gli elementi a disposizione convergono verso questa interpretazione.
L’accordo raggiunto fra Trump e Von der Leyen nel golf club del tycoon in Scozia appare una sorta di sceneggiatura il cui testo è lasciato alla libera esposizione degli attori e non deve stupire se la specifica americana diverge in più punti da quella europea. Più che un’intesa siglata e condivisa sembra una sorta di corda elastica, dove i due capi vengono tirati a discrezione dalle parti, dandone una versione non solo riduttiva o estensiva, ma addirittura non vincolante.
Il primo impulso, dopo averne letto alcuni stralci, sembrava quello di assimilarlo ad una solenne fregatura: dazi niente affatto reciproci a nostro carico al 15%, pochissime se non nulle esenzioni, rinuncia alla tassazione sui profitti delle c.d. “big tech”, impegno ad acquistare dagli Stati Uniti ingentissime quantità di gas liquefatto ed a investire sul suolo americano montagne di dollari.
Interpretato così, l’accordo sembra una Caporetto, una resa a condizioni di smaccato sfavore verso il nostro principale alleato, ammesso e non concesso che possa ancora chiamarsi tale. Poi sono arrivate da entrambe le parti le precisazioni, il tenore delle quali diverge in modo sostanziale su più punti. Uno per tutti: proprio in queste ore la Commissione dell’Unione europea ha precisato una cosa ovvia: essa non detiene i poteri di rappresentanza di uno Stato federale. Ha il mandato per trattare a nome e per conto di tutti i membri, ma poi l’intesa raggiunta deve essere ratificata da ogni singolo Stato.
Dubito che qualcuno si assumerà la responsabilità di non farlo, perché in caso contrario scatterebbero le vecchie tariffe al 30%, ma in ogni caso l’iter di approvazione non sarà certo breve e nessuno potrà imporre tempi più rapidi del necessario.
La conclusione, riassunta con parole chiare proprio dai portavoce della Commissione, è che al momento il patto siglato con la controparte americana non è legalmente vincolante; servirà ancora molto tempo per mettere a punto i dettagli e le varie divergenze interpretative.
Queste considerazioni, come certamente avranno intuito i lettori, non possono che dare adito ad un retro pensiero in puro stile andreottiano: e se l’apparente ed inspiegabile soddisfazione per l’ottenimento del c.d. meno peggio (dal 30% iniziale si è scesi al 15%, comunque assai oneroso) nascondesse l’intenzione di gestire “rebus sic stantibus” il male minore, discutendo fino allo sfinimento degli elementi di corollario, o presunti tali?
Il movente sarebbe duplice: da un lato, spuntare fra le pieghe del trattato una lista di esenzioni su prodotti sensibili, individuati dai Paesi europei in misura limitata ma in ogni caso importante per la loro bilancia commerciale; dall’altro lato, stringere o rafforzare il più velocemente possibile relazioni d’affari con Stati singoli o associati, in modo da attutire il prevedibile impatto negativo sull’export diretto verso gli Stati Uniti.
Siccome queste intese mercantili, al contrario della vulgata trumpiana, richiedono tempo non breve per la loro attuazione, penso che la querelle sui dazi fra USA ed Unione europea, non sarà né breve né dall’esito scontato. Alla fine, tirando le somme, si capirà chi ha vinto e chi ha perso, non solo a livello collettivo, ma anche settoriale con un unico perdente certo: il consumatore americano, che dovrà gioco forza modificare, e non in meglio, la composizione del suo carrello della spesa.
E i pirla? Siamo di fronte ad una categoria di individui alquanto variegata, non solo per il tasso implicito di alloccaggine, valore strettamente personale, ma per la reiterata perseveranza in posture e/o dichiarazioni prive di riscontri e senso comune, ovvero per la deferenza a volte masochistica verso uomini o modelli di comportamento che palesemente remano contro i diritti e gli interessi delle comunità a cui i suddetti “mona”, per dirla alla veneta, appartengono o pensano di rappresentare.
Beninteso, non escludo, tutt’altro, che un bullo di prima grandezza possa contemporaneamente possedere anche quei tipici connotati che identificano un pirla; forse la differenza sta nel fatto che il prepotente “top level” si nutre della consapevolezza di poter usare la forza come arma di pressione e coercizione di massa, mentre il pirla “tout court”, nella sua goffaggine imitativa, ambirà al massimo al ruolo di utile idiota.
Questa precisazione, all’apparenza un po’ fumosa, offre la stura per puntualizzare alcuni aspetti nel dibattito post accordo fra USA ed Unione europea. Suona per alcuni versi un po’ paradossale che i corifei del “meno peggio” siano proprio coloro i quali hanno insistito per mesi sulla necessità di arrivare a trattare in posizione di evidente debolezza. Guarda caso, gli stessi soggetti che si reputano vicini alle idee del tycoon, difensori della sua linea politica.
Qualcuno si è spinto ancora più in là, accusando Ursula von der Leyen e, più in generale, le Istituzioni europee di essere più dannose dei dazi di Trump. Un tempo, di fronte a queste assurdità, si sarebbe parlato di tradimento e connivenza col nemico, ma pare che stia emergendo la proposta di un taccone che coprirebbe il probabile buco causato dal mancato export: rimborsiamo le imprese con soldi pubblici, meglio se provenienti da Bruxelles.
Lascio al buon senso dei lettori la chiosa finale, anche sulla possibile somiglianza fra differenti parti anatomiche, anteriori e posteriori, di questi geni incompresi.