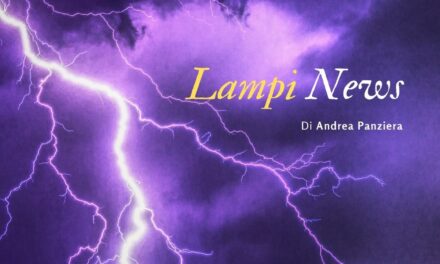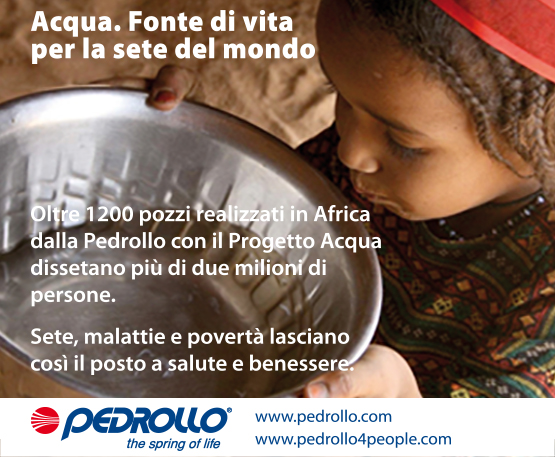Addio a Papa Francesco: un leader forte, dialogante e innovatore, tra sfide storiche e speranze di rinnovamento
Di: Andrea Panziera
LEGGI ANCHE: Lampi News – A gambler in the White House
In queste ore di profonda commozione emerge la forza per molti aspetti rivoluzionaria che ha contraddistinto i quasi tredici anni di Papato di Jorge Mario Bergoglio, primo prelato latino-americano a salire al soglio di Pietro. Forse ce ne renderemo compiutamente conto nei prossimi mesi o anni, una volta svanita l’emotività per una scomparsa non prevista, soprattutto dopo una giornata di Pasqua, che sembrava foriera di ben altre aspettative sulla sua salute. I tentativi di connotare la figura di Papa Francesco come epigono o addirittura capostipite di una supposta corrente più progressista, contrapposta ad un’altra conservatrice, peccano di banale riduzionismo rispetto ad una personalità molto forte, capace di suscitare sì condivisione e ammirazione, ma anche ostilità aperta, o sottotraccia, all’interno stesso della Chiesa. Del resto, la sua biografia parla in termini esaustivi per lui. Nato a Buenos Aires da una famiglia immigrata dal Piemonte, Bergoglio ha trascorso quasi tutta la sua vita nella capitale argentina. Dopo il diploma sceglie la via del sacerdozio e a 22 anni entra nella Compagnia di Gesù. Prosegue gli studi, in particolare di Filosofia e Letteratura e insegna in un liceo. A soli 37 anni diviene capo dei gesuiti argentini, incarico che ricopre dal 1973 fino al 1979. E’ un periodo drammatico, durante il quale si instaura la dittatura militare, che fa scomparire oltre 30mila persone e crea divisioni anche all’interno della Chiesa. Risale a quegli anni lo scontro personale di Bergoglio con la Compagnia di Gesù, che non si ricomporrà mai completamente, ma verrà sopito dopo l’elezione a Papa. Viene da alcuni accusato di una tacita connivenza con la dittatura, in quanto non prende pubblicamente posizione , ma aiuta molte persone a scappare. Regala il proprio passaporto a un dissidente in fuga, sfida i posti di blocco per consentire alla Giudice penale latitante sua amica, Alicia Oliveira, di rivedere i figli. Nel 1992 Giovanni Paolo II lo nomina, un po’ a sorpresa, vescovo ausiliare del cardinale di Buenos Aires Antonio Quarracino. Dal 2005 e fino al 2011 guida la Conferenza episcopale. In quel periodo inizia a farsi notare per l’impegno a favore degli ultimi, poveri, prostitute, carcerati, tossicodipendenti, indigeni e migranti, considerati tutti parte integrante di quello che lui chiama “il popolo di Dio”. Non ha mai aderito alla teologia della liberazione, da lui considerata troppo politicizzata e vicina all’ideologia marxista, ma alla sua variante argentina, la “teologia del popolo”, che colloca le persone comuni e i più fragili al centro dell’azione e dei destini della Chiesa. Tutto il suo Pontificato è stato caratterizzato da parole ed atti concreti che vanno in questa direzione. I suoi concittadini lo vedevano, da Vescovo di Buenos Aires, occuparsi con alacrità instancabile delle periferie più disagiate, girare quel micro mondo a piedi o su mezzi pubblici. Papa Wojtyla lo nomina cardinale nel 1998; lui soggiorna a Roma malvolentieri, perché non ama il clima del Vaticano e non dimora mai in una delle numerose case di proprietà dei gesuiti. Durante il Conclave che ha eletto Papa Joseph Ratzinger, risulta il secondo per numero di voti ricevuti. A far pendere il piatto della bilancia a favore del cardinale tedesco sono proprio i gesuiti, il cui esponente di punta è Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, il quale non si fida del confratello, in quanto lo considera troppo vicino alle idee dei conservatori. Qualche anno dopo Francesco riprenderà un ragionamento dell’arcivescovo ormai defunto, e la sua profezia sulla Chiesa “in ritardo di 200 anni”, in uno dei suoi discorsi alla Curia romana. In queste ore tutti i media pongono l’accento sulle tante prime volte di Papa Francesco: il nome, la provenienza geografica e quella dell’Ordine. Io vorrei ricordare un altro aspetto del suo Pontificato, a me idealmente più vicino, ossia l’apertura al dialogo e la ricerca del confronto con il mondo laico, con le persone che rispettano la fede, ogni fede, ma pongono al primo posto della loro esistenza altri valori. Emblematico, da questo punto di vista, è stato il suo rapporto personale con Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica ed una delle menti più lucide del giornalismo italiano. Riporto alcuni passaggi dei loro dialoghi, che danno il segno compiuto della potenza del confronto, libero da ogni forma di pregiudizio. Papa Francesco: “I più gravi dei mali che affliggono il mondo in questi anni sono la disoccupazione dei giovani e la solitudine in cui vengono lasciati i vecchi. I vecchi hanno bisogno di cure e di compagnia; i giovani di lavoro e di speranza, ma non hanno né l’uno né l’altra, e il guaio è che non li cercano più. Sono stati schiacciati sul presente. Mi dica lei: si può vivere schiacciati sul presente? Senza memoria del passato e senza il desiderio di proiettarsi nel futuro costruendo un progetto, un avvenire, una famiglia? È possibile continuare così? Questo, secondo me, è il problema più urgente che la Chiesa ha di fronte a sé”. Scalfari: “Santità, è un problema soprattutto politico ed economico, riguarda gli Stati, i governi, i partiti, le associazioni sindacali”. Papa Francesco: «Certo, lei ha ragione, ma riguarda anche la Chiesa, anzi soprattutto la Chiesa perché questa situazione non ferisce solo i corpi, ma anche le anime. La Chiesa deve sentirsi responsabile sia delle anime sia dei corpi». Scalfari:”Santità, Lei dice che la Chiesa deve sentirsi responsabile. Debbo dedurne che la Chiesa non è consapevole di questo problema e che Lei la incita in questa direzione?” Papa Francesco: «In larga misura quella consapevolezza c’è, ma non abbastanza. Io desidero che lo sia di più. Non è questo il solo problema che abbiamo di fronte, ma è il più urgente e il più drammatico». Eugenio Scalfari descrive così un altro incontro: “Il Papa entra e mi dà la mano, ci sediamo. Mi sorride e mi dice: «Qualcuno dei miei collaboratori che la conosce mi ha detto che lei tenterà di convertirmi». “È una battuta gli rispondo. Anche i miei amici pensano che sia Lei a volermi convertire”. Ancora sorride e risponde: «Il proselitismo è una solenne sciocchezza, non ha senso. Bisogna conoscersi, ascoltarsi e far crescere la conoscenza del mondo che ci circonda. A me capita che dopo un incontro ho voglia di farne un altro perché nascono nuove idee e si scoprono nuovi bisogni. Questo è importante: conoscersi, ascoltarsi, ampliare la cerchia dei pensieri. Il mondo è percorso da strade che riavvicinano e allontanano, ma l’importante è che portino verso il Bene». Santità, esiste una visione del Bene unica? E chi la stabilisce? «Ciascuno di noi ha una sua visione del Bene e anche del Male. Noi dobbiamo incitarlo a procedere verso quello che lui pensa sia il Bene». Lei, Santità, l’aveva già scritto nella lettera che mi indirizzò. La coscienza è autonoma, aveva detto, e ciascuno deve obbedire alla propria coscienza. Penso che quello sia uno dei passaggi più coraggiosi detti da un Papa. «E qui lo ripeto. Ciascuno ha una sua idea del Bene e del Male e deve scegliere di seguire il Bene e combattere il Male come lui li concepisce. Basterebbe questo per migliorare il mondo». Per questo suo modo di aprirsi, di scendere dal seggio di Pietro e di confrontarsi con il mondo delle idee, Francesco rimarrà per sempre il Papa di tutti, anche di chi non crede ma grazie alla sua visione per lui nutrirà rispetto ed ammirazione indelebili.