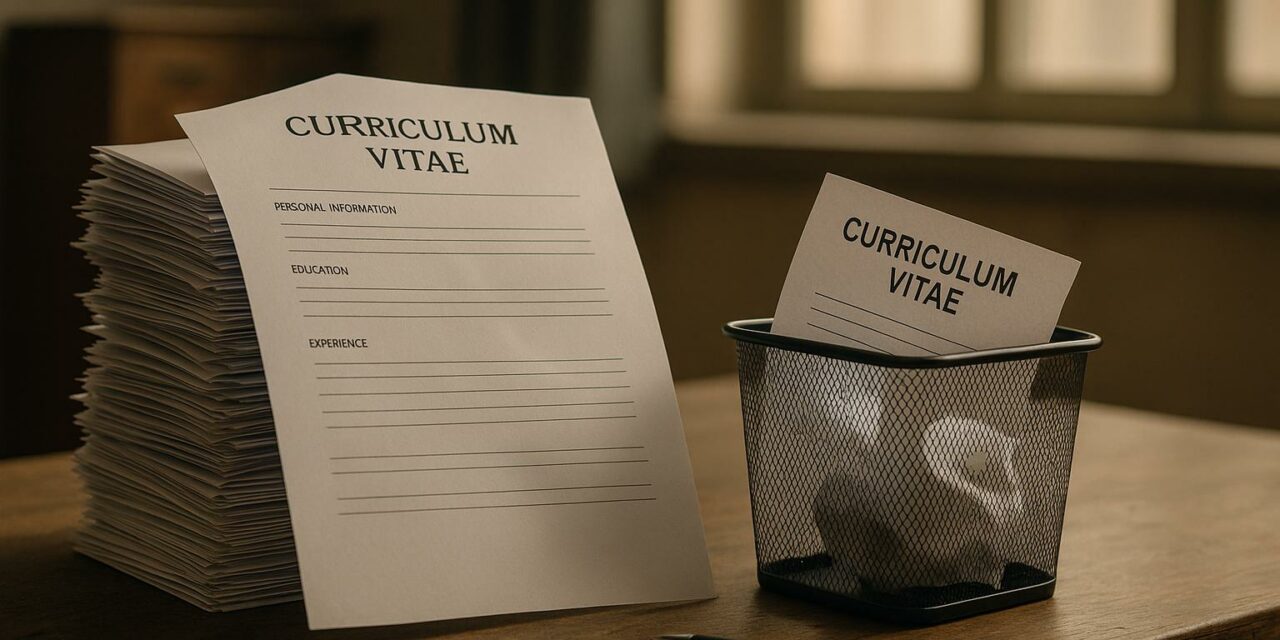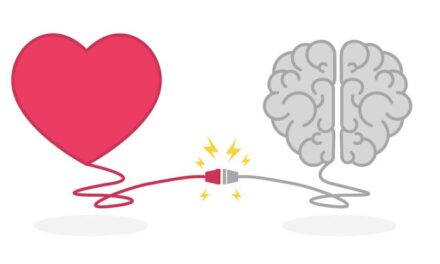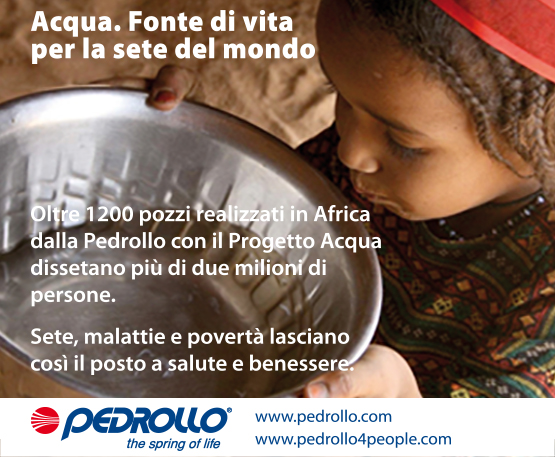Il valore del merito smarrito tra criteri di giudizio ambigui e logiche di potere: cronaca di una deriva silenziosa
Di: Andrea Panziera
LEGGI ANCHE: Post It – Repetita iuvant: dalla parte giusta
Da molto tempo ho smesso di credere che il merito rappresenti un requisito che viene tenuto in considerazione “colà dove si puote”. Carriere, posizioni con potere decisionale, appartenenza a consessi consultivi, attribuzione di incarichi di qualsiasi tipologia e peso, spesso prescindono dai meriti dei potenziali candidati acquisiti sul campo e comprovati da riconoscimenti, attestati di stima, parole di gratitudine proferite o vergate dai beneficiari.
Così va il mondo, dirà qualcuno. La mia ormai lunga esperienza nel mondo del lavoro mi induce a condividere l’affermazione precedente, pur non generalizzandola, con una doverosa postilla: ho la sensazione che il trend sia in costante peggioramento, soprattutto perché appaiono sempre meno chiari i criteri di giudizio su cui si fondano le scelte premiali, inclusive in alcuni casi, oppure palesemente discriminatorie e marginalizzanti in altre.
Una delle cartine al tornasole di questa tendenza, in accelerazione, è la ormai diffusa insignificanza del C.V. In tempi non troppo lontani, il suo peso specifico costituiva uno degli elementi cardine dell’attribuzione di incarichi; la valutazione si basava sia sulle mansioni pregresse, ma anche sulla loro assonanza con il ruolo e coi compiti futuri della posizione da ricoprire. Ad esempio, se la ricerca fosse stata rivolta a trovare il responsabile di importanti contesti formativi con sbocchi futuri in realtà operative, il pedigree della figura prescelta avrebbe dovuto riassumere e acclarare entrambe le esperienze; tradotto, buon comunicatore, profondo conoscitore della materia oggetto della formazione, documentati e ponderosi trascorsi nei contesti operativi, meglio se in posizioni top level.
Questo iter di selezione pare quasi del tutto bypassato, sostituito da altre opzioni: la logica della cordata, l’omologazione alla corrente di pensiero dominante con annesso fastidio per l’opinione dissonante, il presidio di piccoli fortilizi di potere, la prona accondiscendenza ai “desiderata” di entità esterne, le quali chiedono una formazione modellata a loro uso e consumo.
Questa direzione forse potrebbe anche essere consentita in quanto non palesemente “contra legem”; tuttavia, presta il fianco ad almeno due osservazioni, di merito e di metodo. Non tiene conto della velocità dei mutamenti che stanno attraversando il mondo del lavoro: molte delle attuali mansioni c.d. “tecniche” nell’arco di pochi anni verranno spazzate impietosamente via dall’ AI e dalle innovazioni ad essa connesse, con tutte le conseguenze che ciò comporta per i neo assunti.
Più che compiacere i “desiderata” di cui sopra, bisognerebbe dotarsi di una “vision” che vada aldilà dello stretto contingente. Ma, parafrasando Don Abbondio, questa dote è come il coraggio: se uno non ce l’ha, mica se la può dare. Riguardo al metodo, una semplice osservazione: non sarebbe il caso di far precedere ogni scelta dall’ascolto degli utenti destinatari della medesima? Se la decisione passa sopra le loro teste, se non vengono interpellati, se in aggiunta alle classiche locuzioni che dicono tutto e nulla, non si chiariscono gli obiettivi che il servizio vuole raggiungere, non si tengono in alcun conto le loro considerazioni, i loro giudizi e le loro istanze, beh, allora non deve suscitare stupore se la crescita della domanda risulta spesso molto più lenta di quella dell’offerta.
Per concludere, non penso che queste riflessioni di mero buonsenso porteranno a granché. Ma di una cosa sono certo: la gratitudine delle persone a cui sono destinate, che si palesa quotidianamente con parole, messaggi, gesti e concrete manifestazioni di affetto e vicinanza, a dispetto di tutto il resto rappresenta una ricompensa impagabile e indelebile.